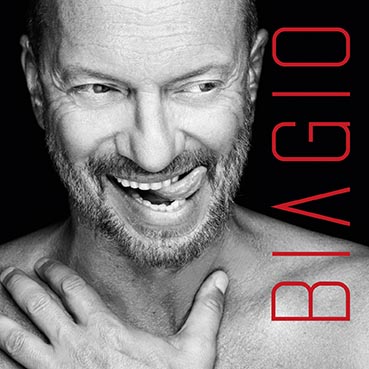Il punk nel suo destino, la musica no-logo come una missione. Sir Bob Cornelius Rifo, in arte Bloody Beetroots, è un ragazzo di Bassano del Grappa che si sta facendo largo da anni sulla scena americana con collaborazioni e dischi remix di successo. Oggi esce con Hide, un album spiazzante, a tratti violento, spesso delicato nel suo osare gli accostamenti più impensabili. Cose che piacciono a chi frequenta rock festival o gioca a videogame spericolati (ha composto musiche anche per quello). Beetroots per “contratto” non si può mostrare per com’è, nel senso che nelle performance indossa sempre maschere diverse. E per l’unica data italiana del suo tour, l’11 novembre all’Alcatraz di Milano, la convenzione sarà rispettata.
Possiamo però svelare che sei nato nel 1977 e che quell’anno l’hai anche tatuato sul petto.
«Sì per me il punk è l’origine di tutto, anche se ho studiato chitarra classica dai 9 ai 15 anni, facevo il solfeggio cantato e tutto il resto. Rifiuti l’insegnamento per i successivi anni ma poi ti resta il gusto per la composizione, anche se non parto dall’accordo per scrivere la mia musica.»
Come nasce un tuo brano?
«Dipende da quello che voglio fare. Anni fa mi sono chiesto se proseguire come dj o musicista. A un certo punto ho scelto la seconda ipotesi concentrandomi sul lato più musicale perché quanto c’è di nuovo in giro? Tutto sembra uguale e quindi sono ancora molto di nicchia ma sono conosciuto più all’estero che in Italia, per quanto riguarda la mia carriera di artista solista.»
Le tue date in Italia sono sempre un evento, però.
«Perché le trasformo in notti da ricordare, anche se è facile fare sold out in posti di provincia. Questa volta c’è un progetto diverso però, il disco si sta facendo conoscere, suoneremo all’Alcatraz e voglio farmi vedere da quante più persone è possibile.»
Intravedi qualche collaborazione mainstream nell’immediato?
«Non credo, non è il mio mondo, ci sono cose che non mi appartengono. Come per esempio quella volta che Enrico Ruggeri mi voleva far duettare con lui a Sanremo, nel 2009. Mi fa piacere essere conosciuti da grandi artisti ma non faccio cose in cui non credo.»
Sei spesso accostato alla scena EDM, Electronic Dance Music, specie in America. È quello il punk del nuovo millennio?
«Non credo ci sia una scena, perché quel termine è stato coniato per l’industria americana che ci ha buttato dentro il dubstep e la dance, devono fare i festival e organizzare i cast. Quindi titolare tutto sotto una sola etichetta è più semplice.»
Cosa trovi di diverso tra l’audience americana e quella europea?
«Che il successo di massa del genere dance in America è tardivo rispetto a noi, non ci sono nemmeno le stesse reazioni, noi qui abbiamo una storia. Il mio pubblico è orientato più ad altri concetti, magari sballandosi con un bicchiere in più. Mentre stanno succedendo delle cose molto preoccupanti ai raduni dance americani. Questo credo sia frutto del fatto che noi abbiamo più storia, anche più informazione riguardo al mondo della notte.»
Nel disco c’è anche un pezzo con Paul McCartney, sembra una fantasia invece è realtà.
«È successo sul pezzo Out Of Sight, dopo che io avevo fatto letteralmente a pezzi il suo cantato nel progetto The Fireman. L’avevo talmente stravolto che quando l’ho riconsegnato al nostro produttore in comune, Youth, Paul ha detto che doveva ricantarlo. Quindi ci ha invitati nel suo studio inglese e con lui abbiamo parlato, lui sapeva che io facevo musica. E da qui è nata la mia richiesta di collaborazione, con lui che ha proposto poi di creare l’outro del pezzo che è completamente suo. Nel mio disco c’è qualcosa di completamente creato da Paul McCartney. Mi sono reso conto di quanto fosse grande quando nel finale della registrazione tutto lo studio era fermo e in estasi. Mi sono emozionato.»